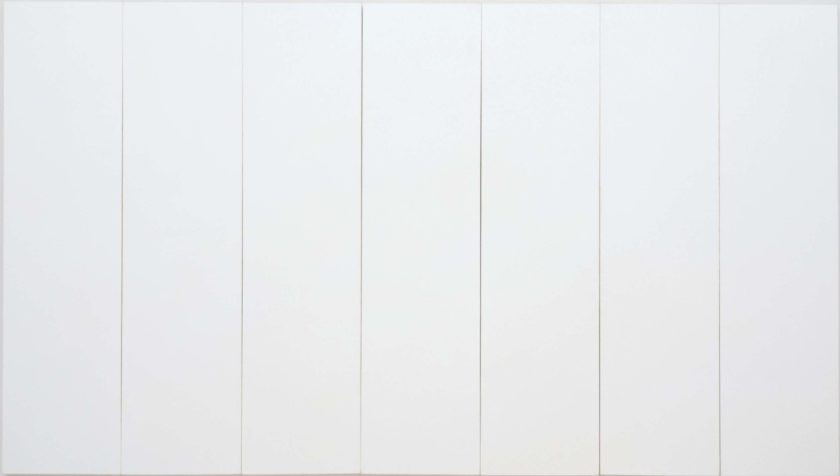Nove anni fa, di questi tempi, stavo lavorando al lancio della startup Cineama, fondata insieme ad altri soci.
Prima di iniziare questa avventura, per almeno tre/quattro anni ho studiato la Rete, le sue filosofie come l’open, i creative commons, le community, la collaborazione e la condivisione. Ho letto libri e megabyte di documenti sul web 2.0. Ho frequentato eventi come i vari “camp” che allora andavano per la maggiore e mi sono confrontato con molte persone provenienti da diversi campi ma uniti dal desiderio di sperimentare le “infinite forme bellissime” del digitale. Ho iniziato a utilizzare in prima persona strumenti come i wiki e i blog. Sono sceso nel dettaglio delle piattaforme emergenti come Joomla e WordPress, progettando e programmando.
In breve, ho studiato. Se aggiungiamo che, al di là del lavoro e della sfera professionale amavo (amo) leggere, guardare film, serie tv e documentari (che insieme possono dare un’idea dello “spirito del tempo”) direi che al momento di ideare la startup avevo ben chiaro l’ambito generale nel quale mi sarei mosso.
A quel punto ho (abbiamo) cominciato il lavoro di focalizzazione, documentandomi tantissimo sull’oggetto della startup, il cinema e l’audiovisivo, visto dalla prospettiva dell’innovazione di “processo” che il web 2.0 e i nascenti social media avrebbero potuto attivare in quel settore. Ho setacciato la rete cercando esperienze, startup, le sperimentazioni in atto e quelle fallite. Ho cercato competitor, punti di forza e debolezza del progetto (insomma, l’analisi SWOT), possibili alleati e partner, in Italia e all’estero. Abbiamo iniziato a partecipare a contest, a bussare alla porta di investitori, fondi di venture capital, business angels e via discorrendo.
Questa lunga e noiosa premessa mi serve per esprimere un mio dubbio: avessi sbagliato approccio?
Sia da discussioni private che da quel che leggo in rete mi sono accorto che molti progetti nello stato iniziale si basano su scarse informazioni del contesto e degli strumenti che si intendono utilizzare (per esempio AI, blockchain, IoT ma anche social media o app) e che diverse startup si buttano in un settore senza averne una grande conoscenza. Questo fa loro affermare, sui loro siti (a volte anche sciatti e sgrammaticati) o nelle interviste di avere un progetto “innovativo”, “rivoluzionario”, unico ecc. La sensazione è che non abbiano fatto ricerche serie ma solo abbozzato un’idea “in vitro” e con quella siano partite in quarta, abbaglòiati dall’illusione del “first mover”. Inoltre non sembrano avere coscienza del meta-ambiente del digitale e dell’innovazione. Per la verità molte volte mi sembra di trovarmi di fronte progetti copia-incolla (l’uber di x, la blockchain per y, deliveroo per z). La cosa che ancor più mi lascia perplesso è che alcune di queste startup vengono “incubate” o supportate da acceleratori di impresa, factory e simili; in questo caso mi chiedo: “ma chi e come ha valutato il progetto?”.
Voglio essere chiaro: io con il mio approccio ho fallito, quindi non posso certo dare lezioni. Forse buttarsi nell’arena della competizione senza preconcetti e con una forte dose d’incoscienza è una buona strategia (meno con una forte dose di impreparazione, forse…).
D’altro canto riconosco subito un progetto costruito con professionalità, umiltà, lavoro di ricerca e approfondimento, cura dei dettagli: trasuda impegno e fatica da ogni bit (non byte).
La domanda che mi pongo — non retorica e non ironica — è questa: dato che fisiologicamente il tasso di successo delle startup è comunque bassissimo, esiste un discrimine a favore di quelle “secchione” rispetto al modello “tabula rasa” (o quasi)?
Mi piacerebbe molto avere un riscontro, un commento da parte di chi bazzica oggi il frenetico mondo delle startup.